NOI SIAMO ALTRI - un libro di Marco Palladini
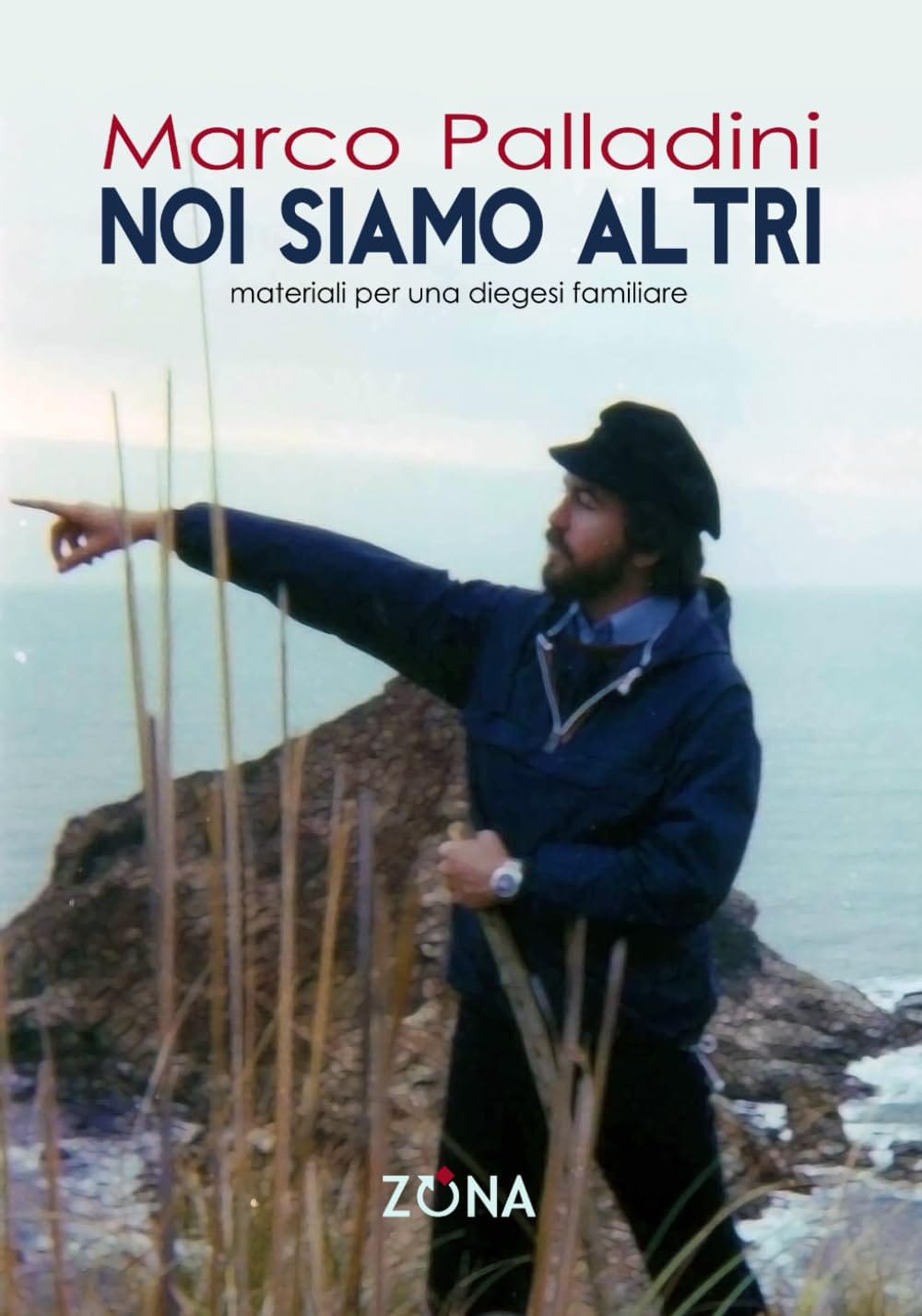
Marco Palladini dichiara subito la regola del gioco: il “noi” non è una casa, è un set di materiali spuri - fotografie, cineschegge, appunti, memorie che si smentiscono mentre avanzano. La tesi viene detta in chiaro nella "Nota dell’autore": «Come l’Io, pure il Noi è una finzione». E il titolo, in filigrana, richiama Rimbaud («Je est un autre», l’“Io è un altro”). Qui l’alterità smette di essere un lampo individuale e diventa grammatica di famiglia. Il noi regge finché riesce a contenere l’Altro; si incrina quando l’Altro diventa quotidiano e irriducibile. È un libro che lavora come palinsesto: raschia, sovrascrive, lascia intravedere strati, poi ci ricasca dentro. L’identità collettiva è una costruzione narrativa, e ogni costruzione narrativa ha un costo: quello di guardare in faccia ciò che la famiglia tende a rimuovere, l’alterità interna che vive a tavola con te.
La forma è già un argomento. Palladini si muove tra romanzo, memoir e saggio: non per indecisione, ma per necessità di materiale. Il lettore entra in un montaggio: referto e affondo, carrellata e colpo secco, senza fingere levigatezze che qui sarebbero menzogna.
Il primo asse, il più duro, è Luciano: il fratello di Marco. La psicosi come perno. Il libro entra da una porta laterale: una notte di gennaio 2025, in tv, il documentario di Bellocchio Marx può aspettare. Subito appare il tono da taccuino: «Dettagli del film: la frase "Marx può aspettare"…». È l’innesco di un cedimento: da quell’appunto Palladini scivola su di sé, ammette deleghe, stanchezze, rinunce. Il referto psichiatrico diventa esposizione. La psicosi di Luciano spacca il linguaggio: costringe a cambiare registro. Palladini rifiuta la retorica della purezza: non santifica il dolore, non vende catarsi. Porta nel testo anche l’imbarazzo, la durezza, la responsabilità. In quei passaggi il “noi” smette di essere pronome e diventa pratica: gestione, sostegno, burocrazia, distanza.
E quando la prosa si ferma, entra la poesia di congedo, La discesa:
«Quando se ne è andato a lungo ho sostato
davanti al suo corpo ormai trapassato,
sulle labbra semi aperte fioriva come un sorriso
simile a quello colmo di beatitudine del Buddha,
la pelle sul volto era liscia e chiara
come se fosse tornato un ragazzo, quel ragazzo
che tanto tempo fa, nei ribollenti anni Settanta,
aveva fatto suo lo slogan prototipico del dropout:
Fermate il mondo, voglio scendere!
E lui, prendendo il motto alla lettera,
era davvero sceso dal mondo».
La poesia consegna l’istante; la prosa ne porta il peso. Da qui in poi il libro smette di contemplare e comincia a fare i conti. Più che interpretare, Palladini mostra la gestione: la famiglia come dispositivo che tenta di reggere, e spesso regge male.
Il secondo asse è Italo, «Il resto del padre». La guerra e la prigionia entrano come depositi: carte, ricordi trattenuti, onorificenze che riaffiorano troppo tardi. La scrittura resta anti-epica, quasi nominativa: elenca senza cantare. Italo sfugge al santino del buon padre e al processo del padre autoritario: schivo e pragmatico, presidia la casa con disciplina e chiusura. La paternità agisce come politica del silenzio. E quel silenzio continua a lavorare anche dopo il funerale.
E poi c’è Andreina. Non come madre da icona, ma come figura di tenuta: proletaria romana, segretaria e dattilografa per vent’anni, orgogliosa della sua piccola pensione. Lei porta la rete: legami, parenti, amiche, energia sociale. E porta una scena: mettersi in posa davanti alla cinepresa, come si recita per restare nell’inquadratura. Il rovescio è concreto: asimmetria del matrimonio e regole minute del maschilismo domestico. E poi il prezzo finale, doppio: prima la convivenza con un figlio folle che la aggredisce e la picchia; dopo, l’Alzheimer che la svuota e la riconsegna a un’infanzia tardiva. In mezzo, una domanda che non smette di tornare: quanto “noi” si regge sul lavoro invisibile di una donna, e cosa accade quando quel lavoro viene meno?
Dentro questo quadrilatero, con l’autore in campo come figlio e fratello, il libro costruisce la sua macchina del tempo: home movies, bobine 8mm, fotografie, cimeli. Lui stesso parla di «schidionata di cineschegge per pura paratassi»: una cascata di immagini che, proprio perché corre, diventa senso. Le bobine registrano la superficie - gite, sorrisi, pose - e rivederle anni dopo è un gesto spietato: la cinepresa seleziona, e ciò che resta in quadro diventa versione ufficiale. Il dettaglio decisivo è un’assenza: il padre filma, poi smette. Anche l’interruzione, qui, è un documento. La fotografia congela una posa e le dà autorità; il cimelio rientra come un ordine di servizio e ti costringe a rileggerlo tutto. È così che l’archivio familiare smette di essere una scatola di affetti e diventa una macchina di montaggio: taglia, accosta, smentisce.
Palladini ragiona come uno che ha imparato che la verità non abita un’unica lingua: abita registri che collidono. È per questo che può parlare di giornalismo e di scena, di Sade e di poetry slam, di attori e di dialetti, senza che sembri un cambio di argomento
Poi c’è la voce, e lì si capisce perché questo libro non sia solo un memoir. Teatro, poesia, performance non sono capitoli di curriculum: sono la spiegazione del metodo. Palladini ragiona come uno che ha imparato che la verità non abita un’unica lingua: abita registri che collidono. È per questo che può parlare di giornalismo e di scena, di Sade e di poetry slam, di attori e di dialetti, senza che sembri un cambio di argomento. Il merito, qui, è l’orecchio: la prosa sa quando deve suonare da palcoscenico e quando deve tornare referto, asciutta e quasi burocratica.
La struttura a capitoli, allora, smette di sembrare disordinata e rivela coerenza. Si procede per addensamenti: il padre e la sua storia, la madre e la sua vita operaia e domestica, la Roma dei poeti e dei giornali, gli anni Settanta riletti senza nostalgia, Berlino come cartina di tornasole delle utopie finite male. Ogni blocco porta un pezzo di risposta alla domanda che resta sotto: che cosa significa essere “noi” quando il noi non è una comunità armoniosa, ma un compromesso tra fragilità incompatibili.
Il libro produce un effetto preciso: impedisce di consumare la memoria come racconto edificante. La mantiene al livello del deposito, con la sua polvere e le sue schegge. Anche lo stile, qui, fa una scelta: accumula e poi stacca; insiste sul dato e poi, all’improvviso, pianta una frase corta che ti riporta al corpo.
Il finale allarga il campo e, invece di chiudere, apre un’ultima ferita: il “Dialoghetto tra un pacefondaio e un realista scettico”, scritto dopo l’invasione russa dell’Ucraina (febbraio 2022). È teatro minimo, di battute: Zeta: «Si vis pacem, para bellum». Alfa: «Giammai! Si vis pacem para pacem». Qui il libro mette il privato davanti a un problema pubblico, senza moralismi e senza posa. La pace come assoluto, la resa come rischio, la storia come specie che non smette di ripetere l’errore. Non c’è soluzione. C’è una consegna: procedere per tentativi, accettare verità parziali, pagare il costo delle scelte.
Noi siamo altri resta, in definitiva, un libro che chiede una lettura da vicino. Non si entra per seguire una trama, si entra per riconoscere un meccanismo: la famiglia produce ruoli, la malattia li sfonda, la memoria li rimonta, la scrittura li espone. Il noi, alla fine, non è un rifugio. È una forza di gravità: ti riporta a terra, nel bene e nel male.
— 𝗠𝗶𝗿𝗼 𝗥𝗲𝗻𝘇𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮
𝐒𝐜𝐡𝐞𝐝𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐨
𝐓𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨: Noi siamo altri. Materiali per una diegesi familiare
𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞: Marco Palladini
𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞: ZONA
𝐀𝐧𝐧𝐨: 2025 (prima ed. ottobre)
𝐏𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞: 257
𝐈𝐒𝐁𝐍: 9788864386201
𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐨: 25,00 €
Acquista: QUI